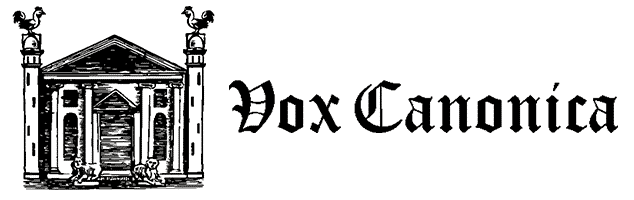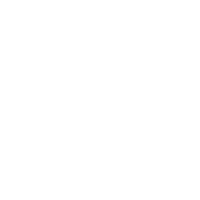José Gallegos, la confessione, collezione privata, olio su tavola, 1879
Un obbligo che non fa sconti
Se l’obbligo del sigillo nasce ex iustitia e ex religione, «il confessore che venisse meno a tale dovere peccherebbe d’ingiustizia verso il penitente e di sacrilegio nei confronti del sacramento stesso»[1]. Il tradimento non avverrebbe solo nei confronti del penitente, ma «anche nei confronti di Cristo stesso che lo ha incaricato di un compito così essenziale e delicato»[2]. In questo senso la violazione del sigillo «colpisce il cuore del sacramento della penitenza»[3]. Tra i diversi documenti utili alla trattazione della materia è opportuno soffermarsi sulla Nota della Penitenzieria che tratta in maniera specifica sul sigillo:
«Al confessore non è consentito, mai e per nessuna ragione, “tradire il penitente con parole o in qualunque altro modo” (can. 983 § 1 CIC), così come “è affatto proibito al confessore far uso delle conoscenze acquisite dalla confessione con aggravio del penitente, anche escluso qualunque pericolo di rivelazione” (can. 984 § 1 CIC).
La dottrina ha contribuito, poi, a specificare ulteriormente il contenuto del sigillo sacramentale, che comprende “tutti i peccati sia del penitente che di altri conosciuti dalla confessione del penitente, sia mortali che veniali, sia occulti sia pubblici, in quanto manifestati in ordine all’assoluzione e quindi conosciuti dal confessore in forza della scienza sacramentale”. Il sigillo sacramentale, perciò, riguarda tutto ciò che il penitente abbia accusato, anche nel caso in cui il confessore non dovesse concedere l’assoluzione: qualora la confessione fosse invalida o per qualche ragione l’assoluzione non venisse data, comunque il sigillo deve essere mantenuto».
La regolamentazione del sigillo
La materia del sigillo è attualmente regolata nei cann. 983-984, dal can. 1456 CCEO[4], dal Catechismo della Chiesa Cattolica al n. 1467[5] e, infine, dal novellato can. 1386 § 1 CIC[6] con la Costituzione Apostolica Pascite gregem Dei, del 23 maggio 2021. Attraverso tale Costituzione Apostolica Papa Francesco ha promulgato il nuovo Libro VI del Codice di Diritto Canonico, De sanctionibus poenalibus in Ecclesia, abrogando il precedente Libro VI De sanctionibus in Ecclesia, che era stato promulgato, insieme agli altri libri del Codice, da San Giovanni Paolo II con la Costituzione Apostolica Sacrae disciplinae leges del 25 gennaio 1983.
Violazione diretta e indiretta del sigillo
Anzitutto, per determinare la responsabilità penale, occorre distinguere tra violazione diretta e indiretta e a ciascuna di queste due fattispecie corrisponde una diversa figura di delitto. La violazione diretta è la rivelazione del peccato e, insieme, del peccatore e non è necessario che il penitente sia conosciuto dai destinatari della rivelazione[7], così come ci sarebbe ugualmente violazione anche se chi ascolta non sa che quanto raccontato dal sacerdote sia stato da lui conosciuto in confessione[8].
La violazione indiretta, che richiede anch’essa il dolo, si ha invece quando: «si rivela la materia oggetto del sigillo sacramentale con delle circostanze che comportano il pericolo di venire a svelare anche il nome della persona o di ingenerare anche solo il sospetto su di essa». In ambedue le fattispecie, affinché ci sia violazione del sigillo deve esserci rivelazione della materia oggetto del sacramento la quale si compone dei seguenti elementi:
«Tutte e singole le colpe gravi manifestate in ordine all’assoluzione sacramentale. Lo stesso fatto che una persona abbia confessato colpe gravi, senza entrare nella determinazione concreta, cade sotto il sigillo sacramentale;
- le singole colpe lievi o peccati veniali. La rivelazione veramente generica che una persona abbia confessato colpe lievi non costituisce violazione del sigillo sacramentale;
- le circostanze della colpa (occasione, fine, luogo, tempo, modo ecc.) dichiarate in confessione, ancorché superflue;
- le circostanze della confessione (penitenza consistente, assoluzione negata ecc.) se da queste può scaturire pregiudizio per il penitente;
- il nome e il peccato del complice».
La violazione diretta del sigillo sacramentale è un delitto che viene punito con la scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica; mentre quella indiretta è comminata una pena ferendae sententiae indeterminata. La ragione della pena della scomunica per questo delitto consiste nel voler tutelare la santità del sacramento; se i fedeli non avessero la garanzia del segreto delle loro confessioni, probabilmente non si accosterebbero a questo sacramento.
Un sigillo che non può sciogliere nemmeno il penitente
Tutte e due i casi di violazione del sigillo sono stati inseriti nelle Normae de gravioribus delictis riservati al DDF (aggiornate il 7 Dicembre 2021) ed il loro giudizio è riservato al DDF (cfr. art. 4 § 1, 5°). I canonisti si sono poi profusi nell’esplicazione per lumeggiare questa normativa, corposa e gravida di storia, così si è sottolineato come l’obbligo di tacere sia al contempo determinato ex motivo iustitiae ed ex motivo religionis[9].
Proprio per questa duplicità non scindibile e ricca d’implicanze che trascende l’interesse puramente personale attraendolo nel rilievo del bonum publicum vel commune, la dottrina, pressoché unanimemente, sia pur dopo qualche querelle, reputa che non si diano exceptiones seu derogationes, e in particolare che neppure il penitente possa sciogliere il confessore:
«Il sigillo sacramentale non tutela solamente il penitente interessato, così che, in base al brocardo “scienti et coscienti non fit iniuria”, quest’ultimo potrebbe liberare il confessore dal vincolo del segreto originato dalla confessione sacramentale. Il sigillo sacramentale è deputato a tutelare (anche) il sacramento stesso e pertanto lo scioglimento del confessore dal sigillo non è nella disponibilità del penitente»[10].
Note
[1] Cfr. E. Miragoli – D. Tettamanzi (a cura di), Il sacramento della penitenza, cit., p. 156.
[2] Cfr. E. Frank, I sacramenti dell’iniziazione, della penitenza e dell’unzione degli infermi: commento ai canoni 834-1007 del Codice di diritto canonico, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2018 Seconda edizione, p. 180.
[3] Cfr. E. Miragoli – D. Tettamanzi (a cura di), Il sacramento della penitenza, cit., p. 156.
[4] Can. 1456 § 1 CCEO: «Il confessore che abbia violato direttamente il sigillo della confessione, sia punito con la scomunica maggiore, con le dovute riguardo al can. 728, 1, n .1; ma se ha rotto il sigillo in altro modo, sia punito con una pena adeguata.
- 2: Colui che ha tentato in qualsiasi modo di ottenere informazioni da confessione o chi ha fornito tali informazioni ad altri punito con la scomunica minore o con la sospensione».
[5] CCC n. 1467: «Data la delicatezza e la grandezza di questo ministero e il rispetto dovuto alle persone, la Chiesa dichiara che ogni sacerdote che ascolta le confessioni è obbligato, sotto pene molto severe, a mantenere un segreto assoluto riguardo ai peccati che i suoi penitenti gli hanno confessato. Non gli è lecito parlare neppure di quanto viene a conoscere, attraverso la confessione, della vita dei penitenti. Questo segreto, che non ammette eccezioni, si chiama il “sigillo sacramentale”, poiché ciò che il penitente ha manifestato al sacerdote rimane “sigillato” dal sacramento».
[6] Can. 1386 § 1: «Il confessore che viola direttamente il sigillo sacramentale incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica; chi poi lo fa solo indirettamente sia punito proporzionalmente alla gravità del delitto».
[7] Cfr. A. Calabrese, Diritto penale canonico, LEV, Città del Vaticano 1996, p. 324.
[8] «Qualche esempio potrebbe essere più utile di molte parole. Il confessore che dicesse “Tizio ha rubato al supermercato”; oppure, senza rivelare il nome, ma permettendo di designare sufficientemente la persona: “il medico, oppure, il maestro di quella frazione, ha commesso …”; oppure: “al primo che oggi si è confessato non ho potuto dare l’assoluzione”, viola direttamente il sigillo sacramentale», E. Miragoli – D. Tettamanzi (a cura di), Il sacramento della penitenza, cit., p. 160.
[9] Cfr. G. Boni, “Sigillo sacramentale, segreto ministeriale e obblighi di denuncia-segnalazione: la ragioni della tutela della riservatezza tra diritto canonico e diritto secolare, in particolare italiano”, cit., p. 72.
[10] G. P. Montini, “La tutela penale del sacramento della penitenza, I delitti nella celebrazione del sacramento (cann. 1378; 1387; 1388)”, cit., p. 226-227.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
©RIPRODUZIONE RISERVATA