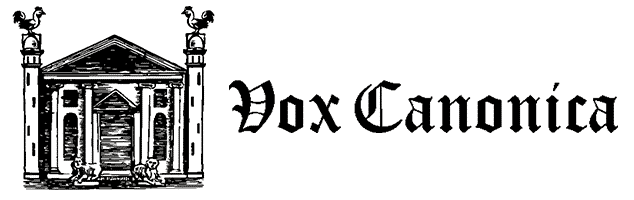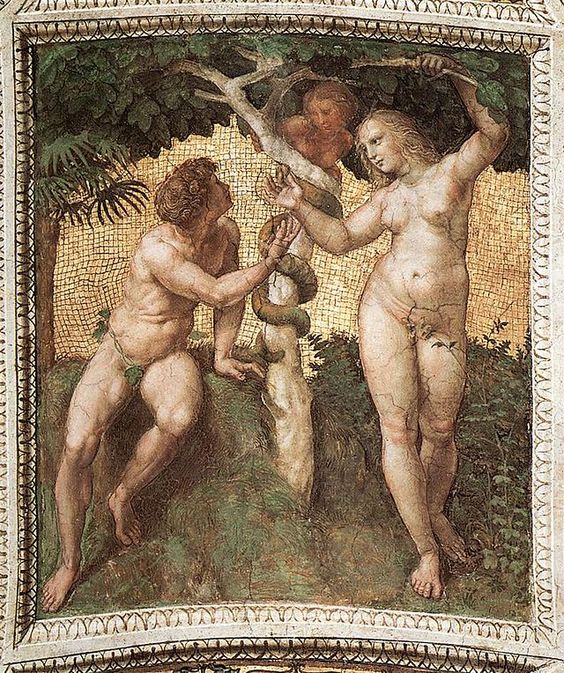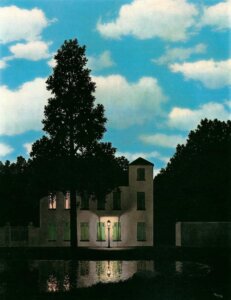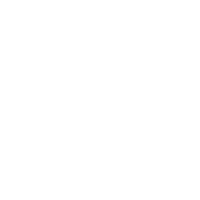Raffaello, Adamo ed Eva, affresco 1508 circa. Stanza della Segnatura, Musei Vaticani
Delitto e peccato, osserviamone le differenze e capiamone i significati
Nelle ultime decadi del secolo scorso la preoccupazione di alcuni pastori nei confronti dei delitti perpetrati dai chierici della rispettiva circoscrizione era solo quella di ottenere il pentimento del delinquente e il suo reinserimento nel corpo ecclesiale, magari nella condizione laicale, dispensandolo dagli obblighi clericali[1]. La necessità di riparare lo scandalo e ristabilire la giustizia era scarsamente apprezzata e considerata, con il conseguente oblio o disapplicazione della procedura penale. Ultimamente invece la giustizia penale è tornata in auge non tanto quale strumento di correzione del singolo, quanto come mezzo per cercare di reintegrare la violazione subita dalle vittime e salvaguardare la collettività. La difesa sociale e la responsabilità di governo paiono infatti dominanti e prioritarie.
L’univoca direzione dell’impegno richiesto può rendere talora poco agevole l’individuazione del confine tra riparazione della colpa e reintegrazione dell’ordine sociale. Appare decisivo pertanto chiarire il rapporto di inclusione ed esclusione reciproca tra peccato e delitto: ogni delitto è un peccato, ma chiaramente non ogni peccato è un delitto. Non si può attribuire un’efficacia punitiva ad un comportamento irrilevante sul piano comunitario ancorché seriamente sconveniente. Una visione assorbente e totalizzante della correttezza o scorrettezza comportamentale porta a sminuire la relativa autonomia e specificità della dimensione giuridica. Il peccato come fatto dirompente della comunione ecclesiale è sicuramente prevaricatorio e detestabile, ma non giustifica certo un’indiscriminata possibilità d’incriminazione e d’addebito. La facoltà di punizione o condanna, oltre alla valutazione prudenziale del titolare del bene leso, dipende dalla qualità stessa dell’offesa.
Il peccato nella chiesa antica
Nella Chiesa antica il peccato rappresentava non solo un male da estirpare ma un autentico attentato al bene comune. Il prevaricatore costituiva quindi una cellula cancerosa nel corpo di Cristo da allontanare e isolare prima che cercare di curare. Sin dagli scritti apostolici la preoccupazione di evitare il contagio e lo scandalo pare prioritaria rispetto al recupero e alla riabilitazione del reo. La comunità peraltro era essenzialmente liturgica, le pene conseguentemente riguardavano fondamentalmente l’aspetto celebrativo. L’ordinamento primigenio dunque non aveva tanto la pretesa di accertare gli estremi del fatto criminoso e l’imputabilità del colpevole quanto di assicurare l’integrità e l’edificazione della santa assemblea[2].
Penitenza pubblica, sovrapposizione penale-sacramentale
In origine mancava la previsione di un sistema penale, non certo l’esigenza e il concreto esercizio della potestà coattiva. La penitenza pubblica non a caso perseguiva gli scopi tipici della sanzione esterna: era al contempo vendicativa, esemplare e medicinale. In quel tempo c’era una sovrapposizione penale-sacramentale, e si deduceva dalla radicata convinzione dall’irremissibilità di alcuni peccati[3], dalla non reiterabilità del perdono e dall’eccessiva onerosità della soddisfazione. La durezza della disciplina non a caso portò col tempo alla desuetudine della penitenza pubblica.
l’imputabilità in riferimento alla concezione antropologica cristiana
Punto di snodo importante, anche se non ancora decisivo, in tale percorso fu la diffusione della penitenza privata. La prassi della penitenza tariffata mitigò la severità del perdono e diede nuovo fulgore al sacramento della confessione. Con la “privatizzazione” della penitenza il foro interno acquisiva una sua rilevanza e specificità. La canonistica classica ebbe il merito di aver precisato il senso dell’imputabilità e la personalità della responsabilità in riferimento alla concezione antropologica cristiana. Fu la decretalistica che ad ogni modo fissò abbastanza chiaramente la distinzione tra peccatum e delictum.
Dal concilio di Trento in poi, respingendo gli errori dei riformatori, la Chiesa rivendicò l’adozione dello strumento penale. Il liberalismo e il razionalismo aprirono anche la strada alla formulazione teorica della pienezza e sufficienza ordinamentale che culmina nella definizione dello ius coercendi nativo e proprio[4].
Le caratteristiche del delitto
La codificazione del 1917 procedette ad un’organica strutturazione e disposizione della materia penale in linea con le precedenti conclusioni, in cui la nozione di delitto fu ormai ben cristallizzata e delineata: le caratteristiche dell’esteriorità della condotta, dell’imputabilità morale e del riscontro positivo della sanzione individuano gli estremi del delictum[5]. La definizione d’altronde conserva la sua validità anche nella regolamentazione vigente. Si registra dunque la continuità e congruenza con l’elaborazione precedente e un’esplicitazione del principio nullum crimen sine actione vel omissione. L’univocità di vedute testimonia la definitiva emancipazione della disciplina penale dalla considerazione teologica del peccato e il riconoscimento della sua valenza propriamente giuridica[6].
Note bibliografiche
[1] Cfr. J. PIEPER, La prudenza, Brescia – Milano 1999, pp. 31-52.
[2] Cf. B.F. PIGHIN, Diritto penale canonico, Venezia 2008, pp. 37-44; V. DE PAOLIS – D. CITO, Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di diritto canonico, libro VI, Città del Vaticano 2000, p. 19.
[3] Cfr. DE PAOLIS – CITO, Le sanzioni nella Chiesa…, p. 29.
[4] Cfr. can. 2214 § 1 del CIC 17 «Nativum et proprium Ecclesiae ius est, independens a qualibet humana auctoritate, coercendi delinquentes sibi subditos poenis tum spiritualibus tum etiam temporalibus».
[5] Cfr. can. 2195 § 1 CIC 17 «Nomine delicti, iure ecclesiastico, intelligitur externa et moraliter imputabilis legis violatio cui addita sit sanctio canonica saltem indeterminata».
[6] M. DEL POZZO, Il rapporto tra delitto e peccato nell’attualità del diritto canonico, in Ius Canonicum, 53 (2013), pp.208-210.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit”
(San Giovanni Paolo II)
©RIPRODUZIONE RISERVATA