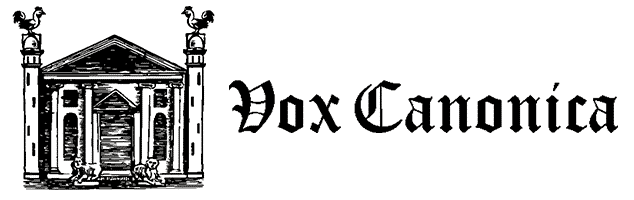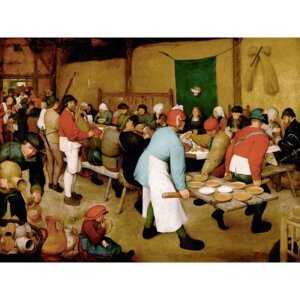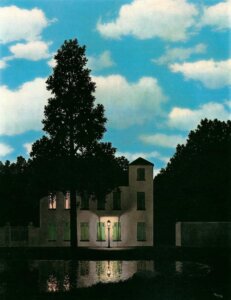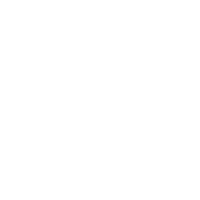In data del 15 aprile 2025 il Pontefice Francesco, con il Chirografo Il ministero petrino, ha riformato la Pontificia Accademia Ecclesiastica, l’istituzione che forma il servizio diplomatico. La riforma è pensata, più che per l’Istituzione stessa, per gli alunni di quest’ultima. Il Pontefice attraverso piccoli accorgimenti e cambiamenti rafforza l’esercizio del dono del sacerdozio per quanti sono chiamati al costante servizio di portare ai popoli e alle Chiese la vicinanza del Papa. L’obiettivo è fornire agli alunni – giovani sacerdoti provenienti da Diocesi di tutto il mondo – una preparazione completa e adeguata alla missione diplomatica loro affidata.
Una diplomazia globale. La Santa Sede nel contesto internazionale
Tutti hanno modo di apprezzare l’opera di mediazione che non di rado la Diplomazia Pontificia ha compiuto in epoca moderna nel contesto internazionale. Nella Dichiarazione Dignitatis humanae sulla libertà religiosa, il Concilio Vaticano II, di fronte alle nuove sfide poste dal mondo contemporaneo, ha ripreso tale principio, ampliandolo e connotandolo in modo duplice. Innanzitutto, esso riguarda la persona umana. Tuttavia, non si fonda su una disposizione soggettiva, ma sulla sua stessa natura. Dunque, un adeguato rispetto del diritto alla libertà religiosa implica l’impegno da parte di ogni autorità civile a «creare condizioni propizie allo sviluppo della vita religiosa, cosicché i cittadini siano realmente in grado di esercitare i loro diritti attinenti la religione e adempiere i rispettivi doveri, e la società goda dei beni di giustizia e di pace che provengono dalla fedeltà degli uomini verso Dio e verso la sua santa volontà» [1].
Nel contesto globale, l’azione diplomatica della Santa Sede è specialmente impegnata nella difesa della libertà religiosa sia nelle relazioni bilaterali, come pure nell’ambito dei diversi organismi internazionali. Concretamente ciò significa anzitutto l’impegno contro la discriminazione dei credenti. Infatti, «troppo spesso, per diversi motivi, tale diritto è ancora limitato o schernito» e «in non pochi Paesi i cristiani sono privati dei diritti fondamentali e messi ai margini della vita pubblica, [mentre] in altri subiscono attacchi violenti contro le loro chiese e le loro abitazioni. Talvolta, sono costretti ad abbandonare Paesi che essi hanno contribuito a edificare, a causa delle continue tensioni e di politiche che non di rado li relegano a spettatori secondari della vita nazionale» [2].
Tuttavia, i fondamenti di ogni società civile non riguardano solamente i summenzionati aspetti. Anche in ambito economico non deve mancare un richiamo etico fondato sulla legge naturale, altrimenti, come ci insegna la crisi finanziaria, i cui effetti sono ancora sotto gli occhi di tutti, finisce per prevalere una concezione soggettivistica dell’uomo, sradicata da ogni fondamento oggettivo, nel quale prevalgono solo logiche di massimizzazione dell’interesse personale a scapito del bene comune. Si tratta di questioni che impegnano sempre più l’azione diplomatica della Santa Sede, soprattutto nel contesto delle Organizzazioni internazionali, in cui non di rado si originano politiche contrarie a tali valori. Inoltre, è un tema che afferisce non solo al cosiddetto Occidente, ma a porzioni sempre più consistenti del nostro mondo globalizzato. In tale prospettiva, è importante sviluppare un confronto con le Autorità dei singoli Paesi, come pure è cruciale poter far sentire la voce della Chiesa anche nei fora mondiali, non solo attraverso la presenza del personale diplomatico, ma anche mediante la proficua collaborazione di esperti locali e delle Organizzazioni non governative cattoliche, che operano in piena consonanza con il Magistero ecclesiale.
L’educazione, base per la costruzione della pace
Una terza direttrice riguarda l’educazione, attraverso la quale si costruisce la pace, si vincono la povertà e le malattie e si realizzano sistemi di diritto equi e rispettosi della dignità umana, come ha ricordato spesso il Pontefice Francesco. Costruire la pace significa educare gli individui a combattere la corruzione, la criminalità, la produzione e il traffico della droga, nonché le tentazioni demagogiche, nonché a evitare divisioni e tensioni, che rischiano di sfibrare la società, ostacolandone lo sviluppo e la pacifica convivenza. La quarta e ultima direttrice che vorrei sottolineare è la carità. Da sempre, essa ha determinato ovunque l’opera della Chiesa. In un certo senso, la Chiesa è essa stessa carità.
E sebbene l’azione caritativa sia garantita attraverso molteplici opere concrete, sovente guidate da singole Congregazioni religiose o dalle Diocesi o Episcopati nazionali, nondimeno la carità è un perno dell’attività diplomatica della Santa Sede, con un particolare impegno a favore dei più deboli, anzitutto in difesa dei diritti delle donne e dei bambini, come pure dei migranti, dei profughi e dei rifugiati. Importante è anche il ruolo che la Santa Sede può svolgere, in collaborazione con gli Stati, nell’ambito delle sfide poste dalla globalizzazione e particolarmente nel contesto di crisi economica che stiamo attraversando [3]. Appare dunque evidente che i rapporti che la Santa Sede intrattiene con gli Stati e con le Organizzazioni internazionali «sono chiaramente di carattere differente da quelli fra Stati-Nazione. La Santa Sede non è una potenza economica o militare.
Tuttavia la sua voce morale esercita un’influenza considerevole sul mondo. Infatti, il principale paradosso è che l’azione diplomatica pontificia sembra muoversi lungo linee tematiche astratte, ossia meramente al livello dei soli principi: coscienza e libertà religiosa, valori non negoziabili, educazione e carità. Eppure proprio queste questioni pongono problemi estremamente concreti, dai quali dipendono gli Stati stessi, la loro convivenza civile, l’avvenire dei fi gli, lo sviluppo economico, la pace tra i popoli. In tal senso, la Diplomazia Pontificia è davvero globale, non solo per l’estensione delle sue relazioni, quanto piuttosto per l’ampiezza dei temi che essa affronta e che riguardano tutta quanta la complessità della persona umana.
Le relazioni internazionali
Per le ragioni suddette, la Santa Sede intrattiene relazioni internazionali con un così grande numero di Paesi, costantemente cresciuto nel corso degli ultimi settant’anni. Infatti, se nel 1945 la Santa Sede aveva 30 nunziature (solo 10 in Europa, a seguito della Seconda guerra mondiale, 19 in America e una in Africa) e 22 Delegazioni Apostoliche nei cinque continenti, oggi i Paesi con i quali la Santa Sede mantiene relazioni diplomatiche sono 180, oltre il Sovrano Militare Ordine di Malta e l’Unione Europea. L’ultimo Paese, in ordine di tempo, è stato il Sud Sudan, il 22 febbraio 2013. Attualmente, la Santa Sede non intrattiene ancora rapporti diplomatici con 13 dei 193 Stati membri dell’Onu, in gran parte in Asia, ma anche in Africa e Oceania. Alcuni entrano nell’ambito delle dieci Delegazioni Apostoliche sussistenti, che, come accennato, sono rappresentanze pontificie senza carattere diplomatico, per Paesi o zone geografi che determinate.
Altri, come Afghanistan, Cina Popolare e Corea del Nord non hanno un rappresentante pontificio assegnato. Per il Vietnam è stato nominato un rappresentante pontificio non residente e senza carattere diplomatico. Come si può notare, si tratta di un numero assai elevato di relazioni, con una presenza molto capillare. Tuttavia, non tutti i Paesi possono contare sulla presenza fissa di un Nunzio Apostolico. Infatti, le rappresentanze pontificie aventi un capo missione residente, di regola un Arcivescovo, sono solo 103. Come avviene per gli Ambasciatori, i Nunzi possono essere accreditati contemporaneamente in vari Paesi. Menzionerò poi le rappresentanze presso le Organizzazioni internazionali [4].
L’atlante di Francesco: diplomazia della misericordia
L’azione svolta dal Pontefice nei dodici anni di ministero petrino fin ora svolto, ci indicano sicuramente il valore profetico dell’azione svolta dal Romano Pontefice attraverso indirizzi dottrinali, nei viaggi apostolici, nella relazione con capi di Stato e di Governo, con le autorità pubbliche, nelle visite alle sedi di organizzazioni internazionali. La diplomazia della Santa Sede esprime questa visione nelle relazioni diplomatiche con gli Stati con tradizioni, visioni religiose e ideologiche diverse. Ma anche nelle organizzazioni intergovernative. In tutte queste sedi internazionali, la diplomazia della Santa Sede dispiega la visione evangelica e profetica del Pontefice. Il volume ha il merito di approfondirla, eleggendo la definizione di «diplomazia della misericordia» [5]. Ricordiamo che nel gennaio 2016 – un anno per molti aspetti drammatico – Francesco, nel discorso al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, arrivò a citare la misericordia ben otto volte. In quel discorso appariva chiaro il legame che egli pone tra la sua visione del mondo, la politica internazionale, la diplomazia e la misericordia.
Che cosa significa la misericordia come categoria diplomatica? Potremmo dire che significa non andare a considerare mai niente e nessuno come definitivamente perduto nei rapporti tra nazioni, popoli e Stati. Nel concreto, invece, la categoria della misericordia applicata alla diplomazia significa l’impegno della Santa Sede, volto a interpretare le situazioni alla luce sia dei princìpi evangelici sia delle regole internazionali. E questo non tralasciando mai gli elementi che pur minimamente possono favorire la concordia e la soluzione delle dispute. La Santa Sede con la sua azione diplomatica sarà, infatti, «sempre disponibile a collaborare con quanti si impegnano per porre fine ai conflitti in corso e a dare sostegno e speranza alle popolazioni che soffrono».
Oggi Papa Francesco lo ripete avendo presenti i vari conflitti in corso nel mondo, e lo ha ripetuto di recente a proposito del conflitto in atto in Ucraina e nella Terra Santa. Il dialogo, anche nelle situazioni più difficili, è voluto in ragione della pace, che sembra essere la grande assente nelle attuali circostanze, a favore della voce solista, alta e tonante, delle armi. Giova, dunque, precisare qui che l’idea di pace di cui la Santa Sede è portatrice non si ferma a quella che le Nazioni esprimono nel contemporaneo diritto internazionale. Essa è infatti convinta che nessuna azione avente a cuore la pace, compresa quella esercitata dalla diplomazia, può essere ragionevole e valida se, anche tacitamente, mantiene ancora riferimenti alla guerra [6].
Le modifiche introdotte dal Chirografo
Tornando, dunque, al Chirografo in modifica dell’assetto della Pontificia Accademia Ecclesiastica, alla luce di quanto detto fino ad ora, si comprende benissimo come l’intento del Pontefice sia quello di una formazione completa e adeguata per svolgere la missione diplomatica nelle varie nazioni, per affrontare le sfide di un mondo in continuo cambiamento, specie nel campo delle tecnologie, per non far venir meno, a fronte del servizio nelle Nunziature, il ministero sacerdotale capace di prossimità, ascolto, testimonianza, dialogo.
In primo luogo, la Pontificia Accademia Ecclesiastica è costituita Istituto ad instar Facultatis per lo studio delle Scienze Diplomatiche. Ovvero, viene configurata quale Istituto di alta formazione accademica nel settore delle Scienze Diplomatiche. Tale decisione si inserisce in una visione più ampia di aggiornamento e qualificazione degli studi ecclesiastici secondo i parametri internazionali propri dell’educazione superiore. Per tanto l’Accademia rilascerà gradi accademici di secondo e terzo ciclo, in Scienze diplomatiche, integrando competenze giuridiche, storiche, politologiche, economiche e linguistiche, con una solida base scientifica.
In secondo luogo, i programmi di insegnamento avranno una stretta connessione con le discipline ecclesiastiche, con il metodo di lavoro della Curia Romana, con le necessità delle Chiese locali e più ampiamente con l’opera di evangelizzazione, l’azione della Chiesa e la sua relazione con la cultura e la società umana. Sono questi, infatti, elementi altrettanto costitutivi dell’azione diplomatica della Sede Apostolica e della sua capacità di operare, mediare, superare barriere e così sviluppare percorsi concreti di dialogo e negoziato per garantire la pace, la libertà di religione per ogni credente e l’ordine tra le Nazioni. Non dimentichiamo che già nel 2020 il Pontefice era intervenuto con una modifica legislativa relativa alla formazione dei nuovi diplomatici, laddove istituiva un anno dedicato interamente al servizio missionario in Africa, Asia, America latina (QUI).
Su questa medesima linea Francesco, ora, avvia di fatto una nuova stagione per quanti, come si legge nel Chirografo, rimangono “l’occhio vigile e lucido del Successore di Pietro sulla Chiesa e sul mondo” anche nei momenti in cui sembra che “le ombre del male abbiano segnato ogni agire di smarrimento e sfiducia”. Dunque non sono più sufficienti le “conoscenze teoriche”, ma sono necessari “un metodo di lavoro e uno stile di vita” che consentano di comprendere a fondo le dinamiche delle relazioni internazionali e di “farsi apprezzare nell’interpretare i traguardi e le difficoltà, che una Chiesa sempre più sinodale deve affrontare”.
In ultimo, il Pontefice, a motivo del fatto che la Pontificia Accademia Ecclesiastica è istituto di formazione del corpo diplomatico, essa sia parte integrante della Segreteria di Stato, nel cui ambito essa opera e nella cui struttura è – a titolo speciale – inquadrata. Questi elementi sono costitutivi di un’azione diplomatica ispirata al Vangelo, capace di costruire ponti, superare ostacoli e promuovere percorsi concreti di pace, libertà religiosa e cooperazione tra le Nazioni.
Note
[1] Dignitatis humanae, 6.
[2] Cfr. Benedetto XVI, 9 gennaio 2012.
[3] Cfr. M. De Leonardis (cur.), Fede e Diplomazia. Le relazioni internazionali della Santa Sede nell’età contemporanea, Milano 2014, 16.
[4] Cfr. Idem, 16-17.
[5] Francesco PP., Incontro con i Rappresentanti di alcune Opere caritative. Discorso presso la Nunziatura Apostolica (Kinshasa), 1° febbraio 2023.
[6] Cfr. P. Parolin, L’atlante di Francesco. Il Vaticano e la politica internazionale, in La Civiltà Cattolica, 1 aprile 2023.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
©RIPRODUZIONE RISERVATA