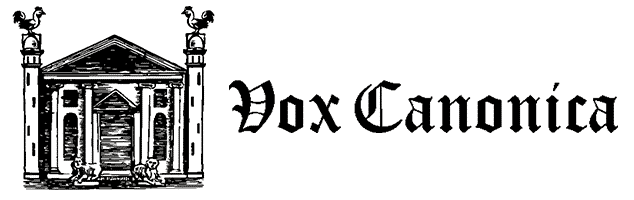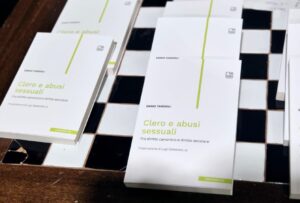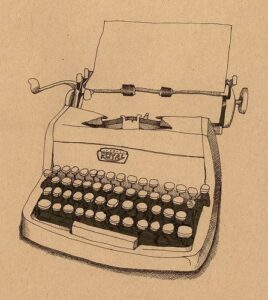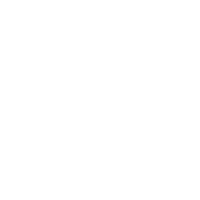Complesso monumentale Donnaregina, Napoli
Introduzione
È esperienza comune, tutt’altro che infrequente, imbattersi in edifici che, pur conservando esteriormente l’architettura e le sembianze di chiesa e di luogo di culto, assumono in realtà una destinazione differente da quella cultuale originaria. Nel gergo comune si è soliti in tali casi parlare di “chiesa sconsacrata”, ma cosa significa realmente questa espressione? E, soprattutto, qual è la disciplina prevista in materia dal Diritto Canonico?
La definizione di chiesa
L’argomento in esame richiede una breve premessa sulla stessa definizione di “chiesa”. Benché possa risultare intuitivo considerarla quale luogo sacro, ordinariamente preposto all’esercizio della propria fede, il Codice di Diritto Canonico, al can. 1214, esplica che: “Con il nome di chiesa si intende un edificio sacro destinato al culto divino, ove i fedeli abbiano il diritto di entrare per esercitare soprattutto pubblicamente tale culto”. Emergono dunque i caratteri della sacralità dell’edificio, della sua destinazione al culto divino e del diritto di accesso di ogni fedele per la pratica religiosa.
In particolare, all’esito dell’edificazione, affinché la chiesa acquisisca il carattere della sacralità, cui segue la destinazione sopra detta, il can. 1217 prescrive che la chiesa debba essere “…quanto prima dedicata o almeno benedetta, osservando le leggi della sacra liturgia”. Per esigenze di sintesi, basti ora precisare che per dedicazione e benedizione si intendono dei riti solenni, ordinariamente presieduti dal Vescovo diocesano o suoi equiparati a norma del diritto (cfr. cann. 1206-1207), affinché nella chiesa possano compiersi “tutti gli atti del culto divino” (can. 1219), come le celebrazioni liturgiche, l’amministrazione dei sacramenti e, più basilarmente, la preghiera individuale e collettiva.
La procedura di riduzione della chiesa a uso profano non indecoroso
Al sussistere di determinate circostanze, può verificarsi l’evento eccezionale in cui la chiesa perda il proprio carattere sacro e, conseguentemente, la sua destinazione alle attività legate al culto divino. Al riguardo, il Diritto Canonico disciplina la fattispecie della riduzione della chiesa a uso profano non indecoroso, definibile quale
“cessazione completa della destinazione al culto soprattutto pubblico di un edificio sacro, qualificato come chiesa, in modo tale che dopo il relativo provvedimento del vescovo diocesano in quell’edificio non possa più celebrarsi il culto e quell’edificio possa essere destinato in forma esclusiva ad altro uso, purché non in esplicito contrasto con la precedente destinazione cultuale” [1].
La disposizione di riferimento è il can. 1222 che, al primo paragrafo, disciplina la fattispecie della chiesa che “non può in alcun modo essere adibita al culto divino, né è possibile restaurarla”: in tale ipotesi, accertata la sussistenza di entrambi i presupposti appena indicati (impossibilità materiale e obiettiva di adibire la chiesa al culto sacro, per le sue cattive condizioni strutturali, e impossibilità di restauro), il Vescovo diocesano può decretare la riduzione della chiesa a uso profano non sordido, senza che debba adempiere ad alcuna formalità previa, restando fermo il prescritto dei cann. 50-51, sulla emissione dei decreti singolari. L’autonomia decisionale dell’Autorità, in questo caso, poggia sul duplice presupposto della oggettiva e evidente inadeguatezza dell’edificio rispetto alla originaria destinazione, da un lato, e della impossibilità di ripristinare l’uso cultuale, attraverso opere di restaurazione dell’edificio, dall’altro. Resta comunque impregiudicato il diritto di chiunque vanti un interesse legittimo di impugnare il decreto di riduzione.
Diversa e più articolata nel suo iter è l’ipotesi disciplinata al secondo paragrafo del can. 1222, che prescrive:
“Quando altre gravi ragioni suggeriscono che una chiesa non sia più adibita al culto divino, il Vescovo diocesano, udito il consiglio presbiterale, può ridurla a uso profano non indecoroso, con il consenso di quanti rivendicano legittimamente diritti su di essa e purché non ne patisca alcun danno il bene delle anime”.
La pronuncia del Supremo Tribunale della Segnatura
La Dottrina e la Giurisprudenza hanno da sempre compiuto un costante lavoro di interpretazione della norma, innanzitutto al fine di delineare il confine delle gravi cause menzionate dalla norma, che esula da quello della causa “gravissima” sotteso all’ipotesi di cui al primo paragrafo del canone [2]. In particolare, valga in questa sede menzionare alcune pronunce del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica che ha considerato legittima la riduzione a uso profano della chiesa nel caso di ingenti danni strutturali della stessa, la cui riparazione, seppure non impossibile, avrebbe richiesto un impegno economico eccessivamente esoso per i parrocchiani [3]; o ancora vi è il caso della palestra, sino a quel momento facente solo provvisoriamente la funzione di edificio di culto, ridotta a uso profano a fronte della edificazione della nuova chiesa parrocchiale [4]. Più in generale è stata ritenuta sussistente la condizione in commento in tutti quei casi di insuperabili problematiche di natura economica. Ad ogni modo, la gravità della causa è presupposto che il Vescovo, nel corso dell’iter decisionale, valuterà avendo riguardo alle peculiari condizioni di tempo, di luogo e comunitarie della realtà ecclesiastica di riferimento [5].
Le ulteriori condizioni richieste, nel caso in esame, per la riduzione della chiesa a uso profano non indecoroso, come chiaramente enunciato dalla norma, sono: l’audizione da parte del Vescovo del consiglio presbiterale, ancorché il parere reso non sia vincolante ai fini della decisione; il consenso di quanti vantino diritti sull’edificio, da intendersi, alla luce dell’orientamento prevalente della Segnatura Apostolica, quali diritti di natura patrimoniale, come quelli derivanti dalle contribuzioni economiche effettuate per l’edificazione della chiesa [6]; infine, si richiede, non come condizione alternativa, ma congiunta a quelle già esposte, che dal decreto di riduzione della chiesa ad uso profano non subisca alcun danno il bene delle anime dei fedeli. In particolare, come chiarito, il danno in parola deve risultare direttamente dalla stessa cessazione della destinazione della chiesa a luogo di culto e non da una reazione impropria dei fedeli alla decisione [7].
La destinazione a uso non indecoroso: linee guida
Ulteriore aspetto di centrale rilevanza attiene alla nuova destinazione dell’edificio, una volta cessata quella originaria legata, come detto, al culto divino. La questione si pone soprattutto per quegli edifici che, attesa la loro struttura architettonica, continuano a evocare la originaria sacralità del luogo [8].
Il can. 1222, al riguardo, sancisce che l’edificio sconsacrato debba essere destinato a un uso non indecoroso, ossia un uso che non entri in netta e manifesta contrapposizione con il carattere sacro riconosciuto sino a quel momento. Sebbene il Vescovo diocesano non sia tenuto a individuare né nel decreto di riduzione a uso profano, né nell’eventuale successivo atto di alienazione del bene a terzi la specifica destinazione futura, senz’altro si riterrebbe opportuno una indicazione in tale senso [9], al fine di prevenire problematiche, pure piuttosto diffuse al giorno d’oggi, circa la opportunità della nuova veste assunta dall’edificio.
Sul tema, ci si riporta a quanto fissato dalla Conferenza Episcopale Italiana, che ha ritenuto compatibile con l’originario carattere sacro della chiesa la destinazione nuova di stampo culturale, tra cui quella di biblioteca, di archivio, di museo [10]; potrebbe ricomprendersi anche quella di auditorium per concerti di musica sacra, ipotesi quest’ultima già regolamentata per le chiese non ridotte a uso profano [11]. Al contrario, come precisato dal Pontificio Consiglio della Cultura, deve considerarsi incompatibile con la precedente impronta religiosa ogni utilizzo commerciale a scopo speculativo dell’ex edificio di culto [12] (tra cui, a titolo esemplificativo, possono individuarsi la destinazione a bar, a ristorante, a locale notturno, a discoteca).
D’altro canto, deve considerarsi opzione preferibile, ove praticabile, quella della continuità nella gestione ecclesiastica dell’edificio anche successivamente alla sua riduzione a uso profano: evidentemente, in tal modo la Chiesa manterrebbe il diretto controllo circa la destinazione del bene, contrariamente a quanto avverrebbe con l’alienazione a terzi, prevenendo scelte inopportune sul punto [13].
Conclusioni
Alla luce di quanto esposto, è possibile rilevare che la complessità dell’iter necessario per la trasformazione di una chiesa in uno spazio a uso profano, purché non indecoroso, sia espressione diretta dell’intrinseco valore comunitario e spirituale dell’edificio stesso. Una osservanza attenta e rigorosa delle formalità prescritte dal diritto può assicurare che la riconversione della chiesa promuova una continuità nella trasmissione del suo originario significato storico e spirituale, valorizzandolo. Ciò in quanto occorre tener presente che
“La cessazione di uno spazio liturgico non comporta affatto automaticamente la sua riduzione a un manufatto privo di significato e liberamente trasformabile in qualsivoglia di diverso, poiché i significati acquisiti da esso nel tempo e la sua presenza reale all’interno della comunità non sono, in realtà, riducibili ad argomentazioni tecniche o finanziarie” [14].
Note
[1] G. P. Montini, La cessazione degli edifici di culto, in Quaderni di diritto ecclesiale, 3 (2000), pp. 282-283;
[2] F. Daneels, Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale, in Ius Ecclesiae, 10 (1998), p. 126;
[3] Ivi, pp. 128-129;
[4] Ivi, p. 129;
[5] Ivi, p. 127;
[6] Segnatura Apostolica, decreto 21.11.1987, in Ius Ecclesiae, 1 (1989), p. 203;
[7] F. Daneels, Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale, cit., p. 132;
[8] C. Azzimonti, A. Fedeli, La riduzione ad uso profano delle chiese e il loro riutilizzo, in Ex Lege, 4 (2002), pp. 89-98.
[9] Pontificio Consiglio della Cultura, La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese. Linee guida, 17 dicembre 2018, p. 270;
[10] Conferenza Episcopale Italiana, I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti, in Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, 35 (1992), p. 331;
[11] Congregazione per il Culto divino e la disciplina dei Sacramenti, Istruzione “Concerti nelle chiese“, 5 novembre 1987;
[12] Pontificio Consiglio della Cultura, La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese. Linee guida, 17 dicembre 2018, p. 271;
[13] Conferenza Episcopale italiana, I beni culturali della Chiesa in Italia, cit., pp. 331-332;
[14] Pontificio Consiglio della Cultura, La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese, cit., p. 271.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
©RIPRODUZIONE RISERVATA