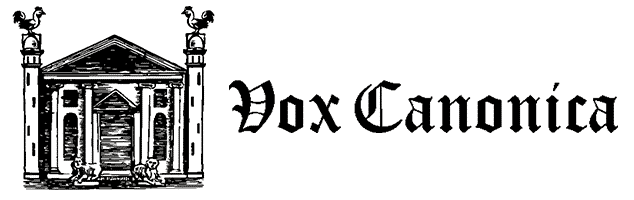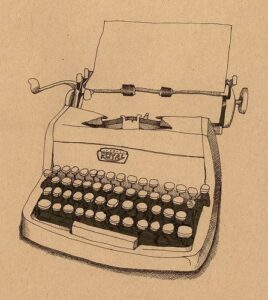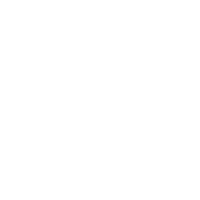Jean Calogero, olio su tavola, proprietà dell’archivio
Uno sguardo analitico alle procedure amministrative del Diritto amministrativo canonico rileva, senza dubbio, talune criticità riconducibili non solamente alla tanto discussa discrezionalità di cui l’Autorità gode, ma anche alla mancanza di collaborazione tra le parti coinvolte nella procedura stessa. Nonostante quanto prescritto dal Codice – ovvero tutto quanto concernente la procedura ad hoc per le varie tipologie previste – nella realtà non sempre si verifica la giusta collaborazione che possa portare alla risoluzione più pacifica e meno controversa della situazione di fatto. Potremmo dunque riportare le criticità del Diritto amministrativo canonico a due filoni fondamentali: Discrezionalità e corresponsabilità, unitamente alla partecipazione.
Una osservazione preliminare
Considerare una riflessione sul Diritto amministrativo canonico tralasciando la sua prospettiva missionaria [1] – la quale ricorda l’insufficienza di uno sguardo solo soggettivo, rispetto ad uno ben più aperto e disponibile all’azione dello Spirito – e ministeriale [2] che si snoda nelle contingenze storiche, sarebbe riduttivo e (forse) insufficiente. D’altro canto bisogna ben intendere cosa sia la missionarietà in relazione al Diritto: non una mortificazione o una deviazione della stretta giuridicità dell’Ordinamento canonico, che rimane integro nella sua autenticità al fine di facilitare la via dei fedeli e non a complicarla ulteriormente [3]. Il Diritto amministrativo canonico non regola una dimensione solipsistica, ma piuttosto tutela una realtà profondamente comunionale.
Un accenno alla discrezionalità
Brevemente, un accenno alla discrezionalità, sempre ampiamente discussa, non può restare inevaso. La discrezionalità è la nota caratterizzante la potestà esecutiva, nonché l’elemento che la differenzia dalla potestà giudiziale; di tale ambito discrezionale abbiamo, anzitutto, riscontro nel Codice (cfr. cann. 87; 135; 1739 C.I.C.), il quale, con diverse disposizioni prevede che il Superiore possa compiere atti di dispensa da Leggi disciplinari (cfr. can. 135 §3 C.I.C.) piuttosto che di revoca di facoltà detenute da soggetti a titolo di vicarietà o delega, a norma del can. 135 §5 C.I.C., sempre dopo aver compiuto una valutazione e ponderazione discrezionale delle situazioni particolari nelle quali si agisce con un Atto amministrativo.
Certamente, in ambito amministrativo, la discrezionalità trova la sua più ampia manifestazione nelle numerose possibilità concesse al Superiore che decide in un ricorso gerarchico contro l’Atto di una Autorità inferiore (gerarchicamente) [4], infatti gli è concesso di confermare o invalidare il Decreto, rescinderlo o revocarlo, correggerlo surrogarlo o abrogarlo [5]. Detto ciò non vogliamo in questa sede elencare i noti limiti della discrezionalità, o della via amministrativa rispetto alla giudiziale, ma sottolineare piuttosto un elemento che la accomuna al concetto, invece alla via giudiziale, nella concezione di iustum.
La motivazione
Quest’ultima, obbligatoria nel decreto quanto nella sentenza, può essere visto come elemento razionalizzante, in quanto rende ragione delle motivazioni – appunto – che portarono l’Autorità a propendere per una determinata decisione e non per l’altra. La discrezionalità, quindi con la corretta applicazione della prassi e con il principio della motivazione – che dà ragione del ragionamento che ha portato alla decisione – trova non un limite ma una razionalizzazione; dunque la facoltà di cui il Superiore gode non è più ostativa al raggiungimento di una giusta decisione se correttamente si è data concretezza ad una procedura giustamente seguita.
Corresponsabilità
Per comprendere al meglio in cosa consista la corresponsabilità di tutti i fedeli – nell’Ordinamento canonico –, riteniamo sia utile riferirsi al concetto di norma missionis [6] del Diritto canonico. In quest’ultima possiamo ritrovare un aspetto bi-univoco, ossia la presenza di due (sub) norme corrispondenti a due aspetti del vivere ecclesiale: la prima (sub) norma e la norma fidei – la quale consente al fedele di poter aderire alla comunità dei credenti, alla Chiesa – riguardante l’aspetto introduttivo, introitale e la norma comunionis, tramite la quale vivere da salvati [7].
Da una siffatta descrizione della norma missionis (per quanto sommaria), deriva una visione della Chiesa e del vivere ecclesiale, distante dal parzialismo della societas, ma piuttosto – in piena armonia con il Concilio Vaticano II – una visione della Chiesa nella quale tutti sono corresponsabili e collaboratori dell’unica missione: la salvezza delle anime, che poi è anche il fine ultimo dell’Ordinamento canonico in questa ottica, dunque il Diritto amministrativo canonico assume una identità del tutto strumentale. L’aspetto comunionale – a questo punto possiamo affermarlo – è comprensibile quale genus della corresponsabilità ecclesiale: volgere lo sguardo alla communio, nella reciproca interazione dei due aspetti della norma missionis, risulta funzionale per la più piena contestualizzazione dell’esperienza giuridica ecclesiale.
Il passo successivo, tuttavia, per riportare l’aspetto della comunione alla piena armonia con il Diritto amministrativo canonico, è la corretta comprensione della communio stessa: non già nella semplice realtà associativa (cum-unus), quanto piuttosto nella realtà più profonda della responsabilità (cum-munus) comune [8]. Infatti, comprendendo la comunione come una corresponsabilità (cum-munus) riguardo la comune missione di ogni singolo fedele, si comprende al meglio anche il ruolo del Diritto (amministrativo) canonico inteso quale sacramento di comunione, ossia dimensione strumentale implicita della comunione ecclesiale, attribuendo il ruolo di instrumentum comunionis (da ristabilire dove e se violata), nella più ampia dimensione della norma missionis.
Quanto fin ora detto circa l’elemento della corresponsabilità nel Diritto amministrativo canonico, della sua importanza, porta ancora una volta a concludere per una incompatibilità rispetto al diritto amministrativo statale, fondato (come ampiamente sottolineato) su presupposti assolutamente differenti e dunque con istituti e norme non direttamente sovrapponibili: l’elemento canonico non coincide con l’elemento societario.
Una conclusione di sintesi
Riteniamo che la formula maggiormente rispondente alle esigenze dell’Ordinamento canonico – in termini di opportunità, giusta discrezionalità e salus animarum – sia quella della partecipazione del soggetto interessato nell’ambito della procedura. Si è avuto modo, in altre sedi (QUI e QUI), di sottolineare come la dialogicità sia alla base del processo giudiziale canonico, ma – riteniamo – che lo stesso possa valere anche per il procedimento amministrativo, tuttavia la dialogicità non potrà verificarsi se non fondata sul principio di partecipazione che ne è fondamento. I ricorsi gerarchici (particolarmente quelli non connessi alle procedure speciali) non hanno una regolamentazione molto approfondita e, lo si è visto, seppur questa sia presente (nelle procedure speciali) comunque potrebbe lasciare spazio a delle lacune, dimostrandosi (talora) non pienamente rispondenti alle esigenze dell’Ordinamento.
Dall’analisi delle norme notiamo una attenzione riguardante la presentazione del ricorso (can. 1737 §1 C.I.C.), la sospensione (cann. 1736; 1737 §1 C.I.C.), la legittimazione attiva (can. 1737 §1 C.I.C.), la nomina del Patrono (can. 1738 C.I.C.) e le modalità decisionali dello steso ricorso (can. 1739 C.I.C.), ma l’assenza di norme precise riguardanti il momento dell’istruzione della causa [10]; viene ricordato solamente – al can. 1738 C.I.C. – l’interrogatorio del ricorrente. Di fronte ad una tale prospettiva si fa essenziale, quindi, il ricorso alle regole giurisprudenziali dettate dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, contenute nelle sue decisioni in quanto capaci di imporsi attraverso una prassi interpretativa e decisionale. Per cercare di dare una prospettiva nell’ottica della partecipazione, pensiamo possa essere utile partire dall’ambito processuale: in una visione che mira a presentare il processo come esempio (anche) per la comprensione del procedimento amministrativo, notiamo che la restrizione delle facoltà del ricorrente, nonché il mancato consenso di presentare prove testimoniali o di essere udito personalmente, configuri una eccessiva restrizione del contraddittorio.
Con ciò non vogliamo affermare che nell’ambito amministrativo, l’Ordinamento canonico non assicuri la difesa del soggetto interessato, infatti anche la procedura amministrativa ha le proprie garanzie di difesa e tutela del singolo; non solo, è essenziale che l’Autorità – chiamata a risolvere la controversia sorta dall’Atto – eserciti il proprio ruolo con una attenzione particolare per il diritto di difesa dei ricorrenti [11]. La presenza del singolo all’interno del procedimento amministrativo deve mirare al perseguimento di finalità altre: coinvolgimento cooperativo dei fedeli, collaborazione per una migliore comprensione e raggiungimento del bene comune, attenzione particolare a tutti gli aspetti del bene comune, anche e soprattutto a quegli aspetti che in assenza del ricorrente non sarebbero considerati.
A ragione di ciò, pur in mancanza di una espressa previsione normativa sul procedimento amministrativo, la partecipazione diventa un riferimento procedimentale ed emerge in tutte le sue potenzialità se garantisce un confronto dialogico e razionale tra argomentazioni e motivazioni del ricorrente e dell’Autorità amministrativa, sempre rivolto alla formulazione di una decisione definitiva, condivisa ed auspicabile, la quale soddisfi la necessità che le valutazioni e le decisioni discrezionali siano precedute da una valutazione logica e comprensibile. D’altro canto è lo stesso Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica a rigettare il contraddittorio sullo stampo esclusivamente giudiziale – nel ricorso gerarchico amministrativo – aprendo (sembra) ad una prospettiva caratterizzata dall’elemento partecipativo.
Note
[1] Cfr. M.J. Arroba Conde, Basi ecclesiologiche e limiti ministeriali di una rinnovata produzione normativa locale, in Folia Canonica, X (2007), pag. 160.
[2] Cfr. T. Citrini, Prospettive teologiche nelle riflessioni sui ministeri, in Rivista liturgica, LVIII (1976), pagg. 585-586.
[3] M.J. Arroba Conde, Le “litterae motu proprio datae” sulla riforma del Processo di nullità matrimoniale: prima analisi. Alcuni aspetti delle nuove norme sulle Cause di nullità matrimoniale, in Apollinaris, LXXXVIII [2015], pag. 554.
[4] Cfr. J. Llobell, Giusto processo e amministrativizzazione della procedura penale canonica. Atti del XV Congresso internazionale di Diritto canonico sul tema: Crime and punishment. Nature, problems and prospective of canonical penal law and relation to Civil law, in URL: http://riviste.unimi.it/index.php/statoechiese/article/view/1150 (consultato il 24/12/2019).
[5] Tali previsioni sono contenute nel can. 1739 C.I.C., osservandolo in comparazione al can. 1004 C.C.E.O. notiamo che in quest’ultimo la discrezione del Superiore è ristretta rispetto al Codice latino.
[6] Cfr. M.J. Arroba Conde, Il metodo del Diritto: comparazione e Utrumque Ius, in Apollinaris, XXXIII (2013), pag. 1062.
[7] Cfr. P. Erdӧ, Teologia del Diritto canonico. Un approccio storico-istituzionale, Torino 1996, pagg. 11-13.
[8] Cfr. P. Gherri, Lezioni di Teologia del Diritto canonico, 2 ed., Città del Vaticano 2013, pagg. 308-309.
[9] Cfr. F. Coccopalmerio, Quid significent verba Spiritum Christi habentes. Lumen gentium 14, in Periodica de Re Morali, Canonica, Liturgica, LXVIII (1979), pagg 553-559.
[10] Cfr. J. Miras, Recurso Jerárquico, in J. Otaduy – A. Viana – J. Sedano (curr.), Diccionario generale de Derecho canónico, VI, Pamplona 2012, pag. 778, che richiama l’importanza delle previsioni sugli Atti amministrativi e sui Decreti e tra queste particolarmente quelle di cui al can. 50 C.I.C.; per un discorso più generale si veda: C. Begus, Adnotationes, pag. 405.
[11] Cfr. J. Llobell, La conferma del Decreto di dimissione del Religioso a norma del can. 700. Note sull’ermeneutica degli istituti rivolti all’attuazione del diritto di difesa, in Ius Ecclesiae, IV (1992), pag. 235.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
©RIPRODUZIONE RISERVATA