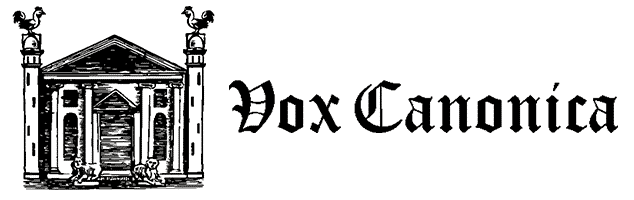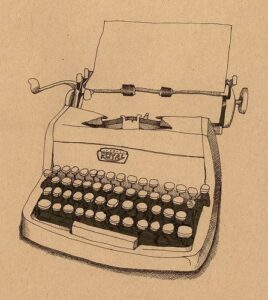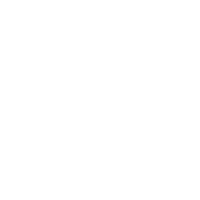Giorgio Vasari, Scomunica di Federico II da parte di Gregorio IX, 1572 circa, Musei Vaticani, Sala Regia
Negli ultimi anni, il diritto penale canonico ha subito una profonda revisione, culminata con la riforma del Libro VI del Codex Iuris Canonici. Tale revisione risponde alla necessità di rendere più efficace la disciplina penale della Chiesa, soprattutto per quanto concerne la lotta contro gli abusi sessuali, che hanno scosso profondamente la comunità ecclesiale e la fiducia dei fedeli.
Il presente contributo intende analizzare i recenti sviluppi del diritto penale canonico e il suo rapporto con l’ordinamento secolare, evidenziando i punti di convergenza e le differenze strutturali che continuano a persistere tra i due sistemi.
Evoluzione del Dialogo tra Diritto Penale Canonico e Secolare
Con la riforma del 2021, il diritto penale canonico ha mostrato segni di avvicinamento ai principi del diritto penale secolare, in particolare con l’esplicita introduzione della presunzione di innocenza nel can. 1321 §1 CIC e con una maggiore determinazione delle pene previste per i reati. Questo rappresenta un cambiamento significativo rispetto al passato, quando il sistema canonico era caratterizzato da una maggiore discrezionalità del giudice ecclesiastico.
Tuttavia, permangono differenze sostanziali, specialmente riguardo alla concezione della pena. Nel diritto canonico, infatti, la sanzione ha un carattere prevalentemente correttivo e pastorale, mentre nell’ordinamento statale essa assume una funzione retributiva e deterrente. Inoltre, l’adesione spontanea del fedele all’ordinamento ecclesiale implica che il diritto penale canonico non possa esercitare una coercizione analoga a quella dello Stato.
Uno degli aspetti più dibattuti riguarda l’efficacia delle pene canoniche rispetto a quelle statali. Mentre il diritto penale secolare prevede la coercibilità diretta delle sanzioni attraverso le forze dell’ordine e le strutture carcerarie, nel diritto canonico l’efficacia della pena si fonda sull’accettazione e sulla consapevolezza del fedele. In altre parole, un soggetto scomunicato, ad esempio, non subisce una privazione della libertà personale, ma viene escluso dalla partecipazione attiva alla vita della Chiesa, con conseguenze spirituali e sociali.
Il Principio dell’adesione volontaria e le sue conseguenze
Uno degli elementi più caratteristici del diritto penale canonico è la centralità dell’adesione volontaria del fedele alle norme ecclesiali. A differenza del cittadino di uno Stato, il fedele entra a far parte della Chiesa attraverso un atto di libera scelta e può decidere di allontanarsene in qualsiasi momento. Questa peculiarità incide profondamente sulla natura delle sanzioni canoniche, che perdono di efficacia qualora il reo decida di abbandonare la comunità ecclesiale. L’adesione volontaria non implica solo l’accettazione delle norme canoniche, ma anche il riconoscimento dell’autorità ecclesiastica come unica fonte legittima di potere giuridico e morale all’interno della Chiesa. Questo elemento rende il diritto penale canonico radicalmente diverso dal diritto statale, in cui l’adesione al sistema giuridico è obbligatoria per tutti i cittadini e non soggetta a una scelta personale.
La consapevolezza di essere parte di una comunità religiosa implica che le pene canoniche abbiano uno scopo non solo punitivo, ma anche educativo e redentivo. Le sanzioni ecclesiastiche non mirano solo a correggere un comportamento illecito, ma anche a favorire la riconciliazione tra il fedele e la comunità, evitando la definitiva esclusione dalla Chiesa.
Il carattere volontario dell’adesione si scontra con la questione della coercibilità delle sanzioni canoniche. Se da un lato la Chiesa non dispone di strumenti coercitivi paragonabili a quelli dello Stato, dall’altro esercita un forte potere normativo e disciplinare sui fedeli, la cui efficacia dipende dal valore che essi attribuiscono alla propria appartenenza alla comunità ecclesiale. Per un credente praticante, l’esclusione dai sacramenti o la scomunica possono rappresentare una pena ben più grave di una sanzione civile o pena.
Un aspetto rilevante riguarda gli effetti giuridici della rinuncia volontaria all’adesione alle norme canoniche. Il Codice di Diritto Canonico prevede che alcuni atti, come la defezione formale dalla Chiesa cattolica, comportino la cessazione di determinati diritti e obblighi. Ad esempio, chi abbandona formalmente la Chiesa non è più soggetto alle sue leggi disciplinari e perde il diritto a ricevere i sacramenti. Tuttavia, non tutti gli effetti della rinuncia sono immediati e automatici. In alcuni casi, il diritto canonico prevede che determinati vincoli, come il matrimonio religioso, continuino ad avere validità anche dopo l’abbandono della fede, salvo diversa decisione dell’autorità ecclesiastica. Questo aspetto mostra come l’adesione volontaria abbia implicazioni giuridiche complesse, che possono estendersi anche oltre la permanenza effettiva nella comunità ecclesiale.
Un caso particolare è quello dei chierici e dei religiosi, la cui adesione al diritto canonico comporta vincoli più stringenti rispetto ai fedeli laici. L’abbandono volontario del ministero ecclesiastico non comporta necessariamente la cessazione degli obblighi disciplinari: un sacerdote dimesso dallo stato clericale, ad esempio, non è più tenuto a rispettare alcuni precetti canonici, ma può comunque essere soggetto a restrizioni disciplinari.
Inoltre, l’ordinamento canonico prevede che alcune pene, come la scomunica, possano essere revocate solo attraverso un atto di riconciliazione con la Chiesa. Questo significa che, anche in caso di adesione volontaria, il sistema canonico conserva un certo grado di coercitività, esercitata non attraverso strumenti di forza, ma mediante la regolamentazione dell’accesso ai sacramenti e ai benefici spirituali.
Questa analisi mostra come il diritto penale canonico, pur avvicinandosi sotto alcuni aspetti al diritto statale, mantenga una propria specificità. Il principio dell’adesione volontaria rappresenta un punto di divergenza fondamentale rispetto al diritto penale secolare. La convivenza di due sistemi sanzionatori paralleli solleva questioni di coordinamento giuridico, ma al tempo stesso ribadisce la separazione tra sfera religiosa e secolare. In un contesto in cui la trasparenza e la collaborazione tra istituzioni civili ed ecclesiastiche stanno diventando sempre più necessarie, il futuro del diritto penale canonico dipenderà dalla sua capacità di mantenere la propria identità pur rispondendo alle esigenze della società contemporanea.
Bibliografia
Llobell J., Il diritto penale canonico: principi e applicazioni, Edusc, Roma, 2019.
Marzoa A., Le fonti del diritto penale canonico e la loro interpretazione, in Ius Ecclesiae, 2021, pp. 37-58.
Negri A., Diritto Penale Canonico e Secolare: Un Confronto tra Avvicinamenti e Distanze, in Sistema Penale, 2023.
Pighin B.F., Il nuovo sistema penale della Chiesa, Marcianum Press, Venezia, 2021.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit”
(San Giovanni Paolo II)
©RIPRODUZIONE RISERVATA