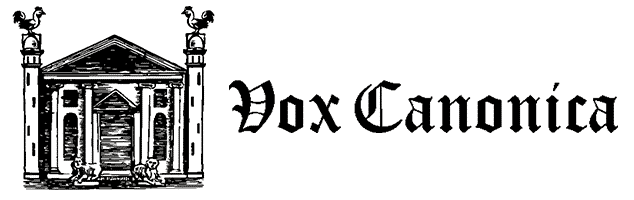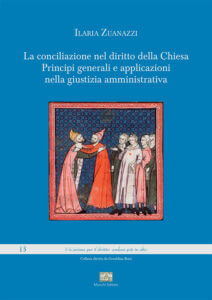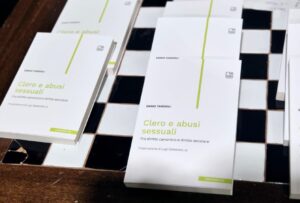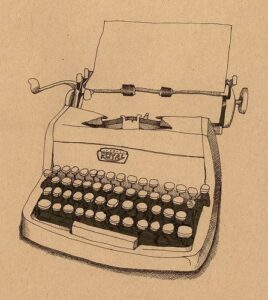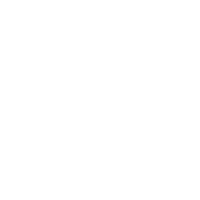Una nuova monografia ne affronta il tema
Poche settimane fa è stata pubblicata una monografia della professoressa Ilaria Zuanazzi, col titolo: “La conciliazione nel diritto della Chiesa. Principi generali e applicazioni nella giustizia amministrativa” (Mucchi Editore, 2024). L’Autrice, Ordinario di Diritto Ecclesiastico e Canonico presso l’Università di Torino, e una delle massime autorità in tema di giustizia amministrativa ecclesiastica, da tempo si è vivamente interessata ai meccanismi alternativi di risoluzione di conflitti come alternativa ai giudizi. Tale interesse per questi meccanismi alternativi si riscontra anche in diversi ordinamenti statuali, e nel fenomeno converge la necessità prammatica di ridurre le incombenze, i costi sociali, economici e personali della litigiosità processuale e di provvedere ad una ottimizzazione delle risorse.
Sennonché nel caso della Chiesa – e questo è un interessantissimo apporto dell’Autrice – l’uso di strumenti di conciliazione ha una storia tutt’altro che recente, affondando le sue radici non già nel diritto delle decretali, ma nelle testimonianze dei Padri e nella propria teologia neotestamentaria. Niente di strano in un’istituzione che riconosce al «principio di riconciliazione» un indubbio valore teologico e soteriologico, per cui si scopre un intrinseco interesse e una quasi intima propensione a esplorare siffatte soluzioni, e ciò per motivi fondamentali e sistemici, ben aldilà di questioni (meritevoli di attenzione, senz’altro) prettamente logistiche o prammatiche, che hanno anche un legame con la rationabilitas che permea l’ordine giuridico. E’ però paradossale come un ordinamento che dovrebbe riconoscere al principio di riconciliazione un asse portante, conceda uno spazio così esiguo circa i meccanismi di prevenzione e risoluzione amichevole delle controversie.
Una possibile apertura
Da un lato, e come la monografia sottolinea, questi meccanismi hanno visto recentemente ridotta la sua esperibilità alle sole cause di bene privato. Sulla distinzione pubblico-privato nel contesto di regolamentazione processuale abbiamo già avuto occasione di parlare. Non si vogliono qui approfondire le ragioni o eventuali giustificazioni di questa limitazione, ma servirebbe una riflessione sulla possibilità di espandere anche a cause riguardanti il bene pubblico la possibilità della risoluzione amichevole, della conciliazione. Non solo perché in ambito pubblico può essere talvolta più rilevante che mai la potenzialità e spinta del principio di riconciliazione, ma anche perché si ha il sospetto che non si dovrebbe trattare tanto del bivio pubblico-privato, ma del bivio (se così si vuole parlare) di ciò che può essere oggetto di risoluzione extra processuale e ciò che non lo può essere.
In questa distinzione gioca un ruolo di non poco conto il fatto che lo strumento processuale è intimamente fondato sul favor veritatis, mentre negli strumenti conciliativi convergono altri interessi che possono contemperare la forza pervasiva dell’accertamento della verità, per così dire. Stando così le cose, alcune materie di bene pubblico, come ad esempio le nullità matrimoniali, probabilmente dovrebbero rimanere a margine. Ma ci sono altre materie, di risvolti nettamente pubblicisti, dove questi meccanismi potrebbero esplorarsi.
Un possibile (e auspicabile) favor conciliationis
Uno di questi campi riguarda le controversie sorte nei contesti dell’attività amministrativa. A questa tematica la monografia dedica un ampio spazio nella seconda parte, con una fitta ricostruzione storica, l’analisi della normativa vigente, proposte concrete e suggestivi rilevamenti. E’ un campo vasto dove si trovano controversie sorte con la chiesa locale o le sue autorità, con Dicasteri o con alcuni fenomeni della vita consacrata. In tutto questo campo potrebbe svilupparsi, appunto, un favor conciliationis, come l’Autrice suggerisce.
Un altro di questi campi è il settore penale. Di per sé, uno tenderebbe a guardare con certa diffidenza la possibilità di strumenti conciliativi in questo terreno, auspicandosi un po’ cinicamente che il meccanismo processuale (assai scadente se si pensa alla sua regolamentazione e non troppo chiara applicazione) venga raffinato e applicato sul serio per poi cominciare a parlare di strade alternative. Tuttavia, l’Autrice rileva (nella prima parte del libro) come storicamente vi è stato uno spazio nel diritto della Chiesa per questi tipi di meccanismi in re poenali. Al giorno d’oggi, inoltre, in molti ordinamenti si stanno proponendo modelli di giustizia riparativa che in certo qual senso condividono questo approccio.
Siffatti strumenti potrebbero fornire, ad esempio, scenari per un maggiore e più proficuo coinvolgimento delle parti lese (le vittime), non solo all’uopo di ricostruire storicamente i fatti ma col proposito anche di offrire loro percorsi di guarigione e riconciliazione, senza dimenticare la dimensione di riparazione dell’ingiustizia che si trova ivi sottesa nonché la dimensione di emendamento del reo. E’ un terreno dove ancora serve approfondimento e riflessione, ma ciononostante è opportuno interrogarsi su queste possibilità.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
©RIPRODUZIONE RISERVATA