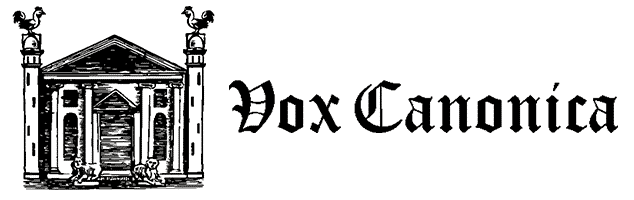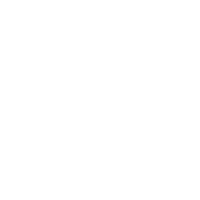La disciplina attuale dello statuto della “vittima”
Come si sa, la pars laesa (ovvero la «vittima», se si acconsente perlomeno interlocutoriamente ad un termine molto diffuso nell’arena mediatica) unicamente può intervenire nel processo penale giudiziale canonico come terzo (cfr. can. 1729, § 1 e 1596 CIC), essendo precluso tale intervento in appello se non fu fatto già nel primo grado di giudizio (cfr. can. 1729, § 2 CIC). Vige dunque un netto monopolio pubblico dell’azione penale nelle mani del Promotore di Giustizia, sebbene tale parte pubblica unicamente presenterà accusa su richiesta dell’Ordinario, il quale tra l’altro è in grado di imporre al Promotore la rinuncia all’istanza (cfr. cann. 1721, § 1 e 1724, § 1 CIC).
Il monopolio o, perlomeno, la preponderanza pubblica nell’azione penale è una scelta di configurazione non priva di senso, come hanno sostenuto non pochi processualisti anche in ambito secolare, ribadendo come in questo modo si evita che lo ius puniendi possa strumentalizzarsi al servizio di quello che è una vendetta mascherata. Si tratta di un tema discusso in diritto comparato, con soluzioni e scelte operative non uniformi (in Italia, ad esempio, lo spazio per parte lesa è fortemente contenuto, in Spagna invece molto più ampio con la c.d. accusa popolare).
Nel nostro sistema, lo spazio per la parte lesa è assai ridotto. Si limita ad un intervento (generalmente adesivo) in vista della refectio damnorum ob delictum (intervento precluso se non fu fatto già nel primo grado di giudizio), con un ius appellandi limitato alla questione dei danni (il che pone la questione se il gravame si limiti ad una difettosa quantificazione o se in qualche modo possa indirettamente approdarsi anche al merito della fons damnorum). La disciplina della procedura penale amministrativa non prevede esplicitamente l’intervento della pars laesa. A ciò si aggiunge che la pars laesa non avrebbe, di per sé, diritto ad essere teste, perché a rigore uno non ha diritto ad essere teste (il can. 1549 CIC riguarda l’idoneità ad essere considerato come tale, ma non un diritto a diventare teste). Piuttosto vi è il dovere di rispondere se qualcuno è chiamato come teste perché la sua testimonianza è lecita è soprattutto utile (cfr. can. 1527, § 1 CIC) alla ricostruzione dei fatti. Infine, il Codice (e la legislazione penale speciale in tema di delitti riservati) non stabilisce nulla sul dovere d’informazione alle «vittime», nemmeno allo scopo di offrirgli il diritto di azione riguardo ai danni.
Segnali dalla dottrina e dalla prassi
Un’impostazione del genere è ultimamente diventata (o perlomeno così sembra a chi scrive) oggetto di severa critica da parte di non pochi processualisti, ovvero, giuristi attivi nel mondo accademico ma anche operatori del diritto che fanno continuamente i conti con la realtà della prassi forense: essi ritengono che lo statuto processuale della parte lesa – della vittima, se così vogliamo parlare – è troppo insignificante. Non si tratta di lamentele sorte in ambito mediatico o paventate da chi è alieno alla realtà del diritto della Chiesa, ma si tratta di proposte e critiche che provengono da giuristi rigorosi e – cosa molto rilevante – in continuo contatto con la prassi forense in campo penale. Penso ad esempio ad alcuni recenti interventi in ambito accademico di Mons. Carlos M. Morán Bustos, processualista e Decano della Rota della Nunziatura in Spagna, tribunale da qualche anno dedicato in buona (se non maggioritaria misura) a cause di natura penale. Ebbene, Mons. Morán manifestò il suo stupore per questo rachitico spazio concesso alla vittima nel convegno organizzato dalla Pontificia Università della Santa Croce nell’aprile 2024, e di recente in un suo articolo su Estudios Eclesiásticos ha insistito nuovamente sul punto
E non si tratta di un caso isolato: avvocati e giudici di ampia esperienza e rigore, e in contatto con la prassi forense, sollevano perplessità simili. E questo dovrebbe incoraggiare alla riflessione scientifica a prestare attenzione a queste richieste, non sia mai che si possa finire racchiuso in una torre d’avorio facendo i conti senza l’oste: la riflessione e la dottrina possono orientare la prassi, ma la prassi interpella e sfida anche la riflessione e la dottrina. Ovviamente, le proposte vantate in questo senso sono varie. Per coloro ai quali non convince il monopolio pubblico dell’azione penale, spicca naturalmente la proposta di rendere alla pars laesa una vera e propria parte nel processo penale, il che richiederebbe una riflessione approfondita e una riforma notevole dell’impianto processuale. Sebbene forse in futuri articoli ci soffermeremmo su questa possibilità, oggi invece vorremmo unicamente far spuntare una proposta diversa.
In altre parole, si potrebbe prendere più in considerazione la posizione della vittima senza smontare comunque il monopolio pubblico dell’azione penale e i vantaggi che esso può avere?
Una proposta de iure condendo per un rinnovato statuto della “vittima”
Una risposta positiva, che richiederebbe però certe integrazioni de iure condendo, sarebbe comunque possibile. Ci si consenta di illustrarla per sommi capi, tratteggiando il seguente ipotetico e fantasioso scenario: il Promotore di Giustizia è un soggetto (un ufficio) con un ambito di maggiore autonomia nei confronti dell’Ordinario. Al Promotore è demandato il compito di ricevere le segnalazioni e svolgere le dovuta indagine previa (ossia, il ruolo d’inquisire una volta demandato all’Ordinario è ora affidato al Promotore di Giustizia).
A conclusione dell’indagine, il Promotore di Giustizia ha il dovere di avviare l’azione penale (che solo può trattarsi in via giudiziaria, perché la via penale amministrativa è scomparsa, subentrando al suo posto un processo giudiziario abbreviato) se si corroborano indizi razionali di criminalità: in qualsiasi caso, il Promotore deve dire perché procede (vi sono indizi fondati e razionali di criminalità) o perché archivia gli atti senza procedere (tali indizi non sussistono).
Soltanto l’Ordinario, con decreto motivato, e con precettiva informazione da parte del Promotore che si dispone ad interporre il libello, potrebbe bloccare la nascita dell’azione perché ritiene (fondata e motivatamente) che si possono adempiere alle finalità della pena in modo diverso (che vanno esplicitate, con eventuale sospensione della prescrizione dell’azione). Il Promotore è obbligato a informare al denunciante sul corso della denuncia (tutelando comunque il diritto all’intimità e alla buona fama di altri soggetti coinvolti, nonché la riservatezza necessaria alla funzionalità dell’indagine) e a informare alla parte lesa del diritto che le aspetta di partecipare al processo in merito al risarcimento.
Il Tribunale, nell’ammettere il libello e citare il reo, deve verificare che l’offerta di azione alla parte lesa sia stata fatta. Il Promotore è più protetto di quanto lo fosse prima nella sua carica: si prevede una scadenza di sei anni, e per rimuoverlo prima della scadenza serve licenza della Segnatura Apostolica. Esiste una maggiore comunicazione tra i Promotori delle diverse circoscrizioni, con addirittura un Promotore coordinatore (di ambito magari interdiocesano, provinciale o nazionale?) che permette la collaborazione e addirittura l’affidamento gli atti a un Promotore diverso per venire incontro a problemi di connessione di cause, determinazione di competenza…
La descrizione di quest’onirico palcoscenico potrebbe continuare ancora, ma la domanda è se forse in questo modo la pars laesa si sentirebbe più protetta da un sistema che agisce con maggiore trasparenza, con un’azione penale che seppure monopolizzata diventa obbligatoria e nelle mani di un soggetto preparato, qualificato e con un maggiore grado di autonomia funzionale, un ufficio che agisce in veste della tutela della legalità entro la quale si comprende, anche, la tutela della posizione dell’offeso.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit”
(San Giovanni Paolo II)
©RIPRODUZIONE RISERVATA